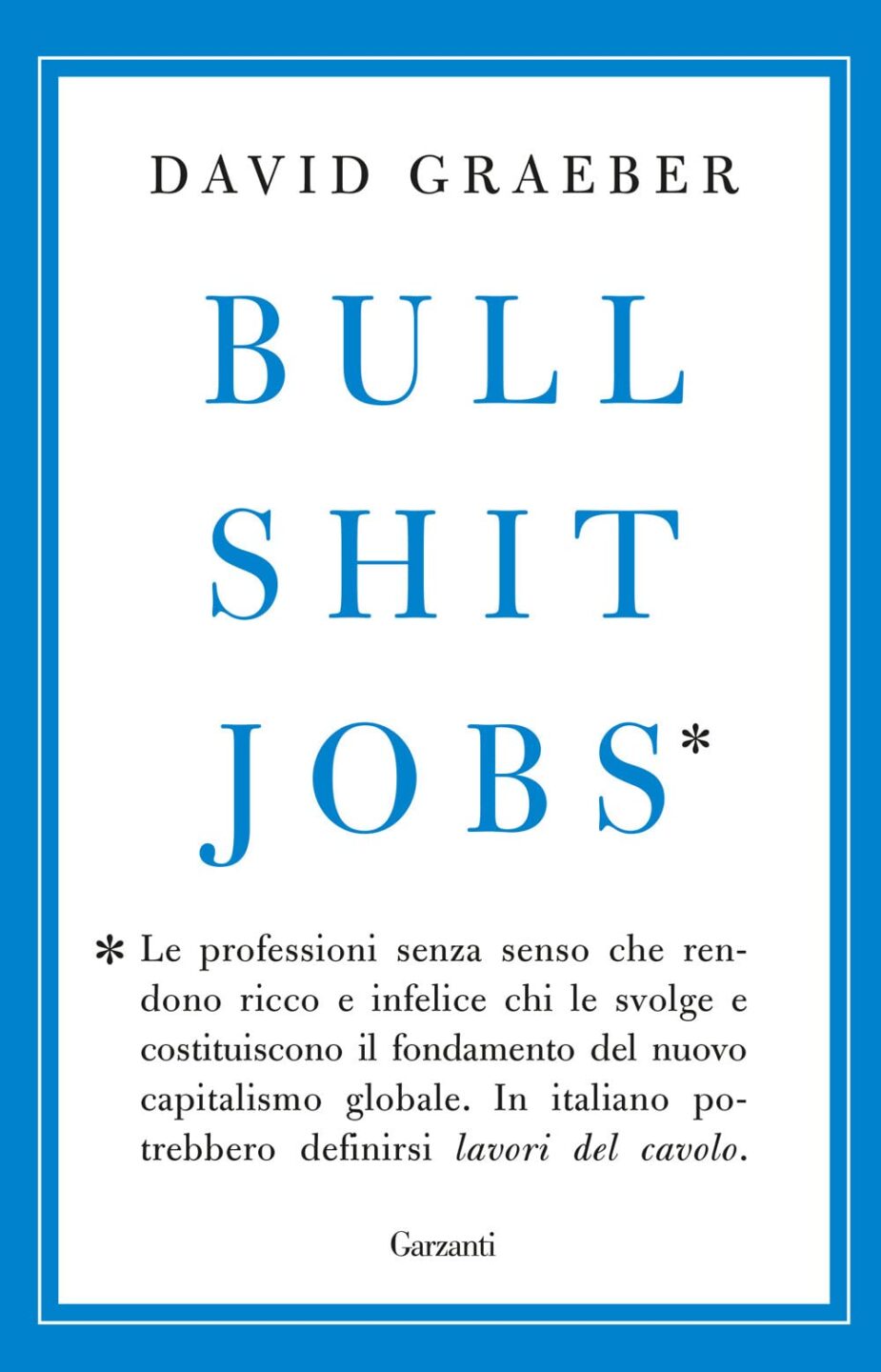Il bello dell’estate? È che si può sempre rimandare tutto a settembre, che è un po’ il turning point della società contemporanea: una soglia immaginaria temporale e spaziale, oltre la quale si trovano l’alfa e l’omega di tutte le nostre attività, gli estremi dentro i quali consumi e desideri dei sapiens (di questa parte del mondo) vengono cadenzati e ritmati, come una musica ripetitiva.
I corsi di jiu-jitsu, gli esami di riparazione, gli orari scolastici, le diete, i campionati, i trasferimenti, gli obbiettivi da raggiungere, il mangiar sano. Tutto deve prendere e riprendere forma a Settembre, la fenice che sorge dalle ceneri di agosto e che immancabilmente diventa lo spazio-tempo anche di una certa nostalgia.
Nostalgia del poter rimandare, del non dover fare. Nostalgia di un tempo “libero” dagli impegni, che sono macigni che schiacciano donne e uomini contemporanei, felici solo potenzialmente, ma realmente quasi sempre infelici.
Sì, perché Settembre è anche lo spazio-tempo della routine, una sorta di trappola da cui non si intravede alcuna uscita, almeno nel breve periodo.
Ma siamo sempre stati intrappolati nella routine? O meglio ancora, siamo tutti intrappolati?
La risposta alla prima domanda è “no”. La routine ha origine con la nascita del lavoro in fabbrica, poi con l’organizzazione della società intorno alla fabbrica.
Dunque è un concetto moderno. Infatti usiamo una parola francese, o meglio illuminista per chiamarla, mentre non abbiamo parole italiane per definire la replica all’infinito di giornate simili tra loro dal punto di vista lavorativo. Poco importa se la fabbrica qui c’è sempre meno. Il tempo continua ad essere scandito da quei ritmi. Otto ore, se sei fortunato. Prendere o lasciare. Se no anche dodici, quindici.
O ti va bene, o chiedi il reddito di cittadinanza.
Anche la risposta alla seconda domanda è “no”. Non siamo tutti intrappolati nella routine.
Ve li immaginate, per esempio, gli Yanomami delle foreste pluviali dell’Amazzonia, che si sentono fiacchi perché hanno finito le due settimane di vacanze che gli spettavano e gli tocca da adesso in poi svegliarsi tutti i giorni alla stessa ora per svolgere un lavoro di otto ore che ritengono essere totalmente inutile?
Mettiamola così: gli Yanomami hanno altri problemi, tipo resistere alle imprese di estrazione mineraria e agli allevamenti intensivi che li hanno praticamente relegati a un lembo di terra, minacciando la loro sopravvivenza. Ma a parte questo particolare, difficilmente il loro tempo è impiegato in attività che essi stessi ritengono inutili.
Questa prerogativa è nostra e solo nostra. È talmente moderna da essere attuale. È la nostra grande condanna. È ciò che ci fa odiare Settembre e tutto ciò che ne segue. Persino i Green Day cantavano “Wake me up when September ends” (Svegliami, quando finisce settembre).
E ce lo dice pure David Graeber.
>
Personalmente, c’è stato un periodo della mia vita in cui pensavo di fare un lavoro utile.
Insegno. Dalle superiori all’università. In Italia e fuori dai confini nazionali.
In aula si ride, si impara. Ci sono stimoli, scambi, è molto bello, o almeno lo sarebbe, se non fosse che insegnare rappresenta solo il 10% del lavoro.
Tutto il resto, direbbe David Graeber, è Bullshit: lavoro del cavolo. Compilazione di verbali e documenti che mai nessuno leggerà. Riunioni e dipartimenti in cui si passa il tempo a non dire nulla, se non letteralmente a “fingere di lavorare”, così che finisca la solfa degli insegnanti che lavorano poche ore a settimana. Firmo lettere e tesi di dottorato che non sono tenuta a leggere, così, solo per rappresentanza. Faccio colloqui con genitori che sono a metà strada tra la seduta psicologica e il confessionale dei parroci. C’è chi ne esce stremato. Chi, subito dopo, se ne va a piangere in silenzio nei bagni dei docenti. Finisco in labirinti burocratici ogni volta che devo esprimere un giudizio. Purtroppo però, il sistema di formazione vuole che i docenti li esprimano, ‘sti benedetti giudizi. Rendere complicato una cosa che bisogna fare di default non serve ad altro se non a giustificare le ore passate a giustificare i voti.
Ho fatto corsi sulla sicurezza come se dovessi andare a lavorare in un’officina, o nelle forze armate.
Ho passato ore a seguire corsi per usare il registro elettronico, per mandare mail, o corsi di aggiornamento su come si compila il verbale del verbale…
Se mi chiedeste adesso se abbia un senso il mio lavoro? Risponderei “no”, non ha senso. Va rotto il grande tabù sul lavoro contemporaneo. Non si può dire, ma lo vogliamo dire.
La maggior parte delle cose che facciamo per lavoro non hanno alcuno scopo né una reale e significativa ricaduta sulla società.
Qualche anno fa, Graeber fece un’etnografia su questo tema. La domanda principale attorno a cui raccolse testimonianze dai Paesi più svariati era: “Credete che i vostri impegni abbiano ragione di esistere”? Oltre il 40% delle persone intervistate aveva risposto in maniera negativa.
>Il fatidico mese di Settembre è anche il mese dei concorsi. Così, tra gli altri, a Napoli si è svolto un concorso per 500 posti da operatore ecologico, cioè addetto allo spiazzamento o alla raccolta di rifiuti. Si sono presentate 26.114 persone. Di queste, 1200 erano laureati, 10.000 erano diplomati anche se si richiedeva la licenza media.
Sì, ok, questi numeri li spiega la situazione di crisi o di disoccupazione in cui viviamo.
Ma se non fossero abbastanza queste due ragioni, per spiegare questi numeri? E se i lavori di ufficio, o quelli di prestigio, spesso marcati da una totale assenza di scopo, fossero in fin dei conti diventati poco appetibili? E se, a parità di stipendio, si preferisse semplicemente fare un lavoro utile, come lo spazzino?
“Per lavoro senza senso si intende un’occupazione retribuita che è così totalmente inutile, superflua o dannosa che nemmeno chi la svolge può giustificarne l’esistenza, anche se si sente obbligato a far finta che non sia così”. Così dice Graeber. Il danno psicologico e spirituale che deriva dallo svolgere nel corso di un’intera esistenza, giorno dopo giorno, lavori senza senso può essere uno dei motivi perché così tante persone (più di 26mila!) non disdegnerebbero di andare a pulire le strade della città. Ma c’è dell’altro.
Per anni ci hanno raccontato che la felicità era intrecciata alla realizzazione professionale. Se fai un bel lavoro, sostanzialmente, sei felice. Ma poi la verità è venuta a galla. Non è vero che la felicità dipende dal lavoro, le variabili sul benessere umano sono talmente tante, che non si possono misurare, quantificare, né possono esserci dei vademecum veramente efficaci per raggiungerle.
Ma allora, se la felicità non dipende dal lavoro che si svolge e se la metà di tutto il lavoro svolto nella nostra società potrebbe venire eliminato senza che faccia alcuna vera differenza, questo significherebbe che… Potremmo anche vivere senza passare la maggior parte del nostro tempo lavorando.
>
Gli Yanomami “lavorano” cinque ore al giorno. Parlo di loro per simpatia, ma potrei parlare di molti altri gruppi umani: non esistono società di cacciatori e raccoglitori che passano una maggior quantità di tempo impegnati in occupazioni di fatica. E nemmeno i nostri cugini primati lo fanno. O sono scemi loro, o lo siamo noi.
Pensiamoci.
Ma noi non siamo cacciatori e raccoglitori, direte voi. Certo, ma non siamo nemmeno più agricoltori, vi rispondo. Abbiamo abbastanza tecnologia da permetterci di non stare dieci ore al giorno a guadagnarci da vivere.
E, se ci pensate, l’idea di un maschio alfa che passa molte ore al giorno a lavorare come un modello appetibile e positivo sono un mito che progressivamente stiamo smantellando anche qui.
Piano piano, lentamente, gli ultimi decenni hanno visto dei piccoli, seppur flebili, moti di resistenza ai “lavori del cavolo”. La recente ondata di dimissioni che in tutto il mondo ha seguito la pandemia è strettamente collegata a questa strana sensazione, tutta contemporanea, di stare impiegando il proprio tempo inutilmente.
Per centocinquantamila anni abbiamo lavorato 4 o 5 ore al giorno e passato il resto del tempo a produrre senso. Con le parole, con i gesti e le danze, con le preghiere, con i disegni, con l’arte, con l’ingegno. Non siamo una specie da lavori inutili, suvvia. Riscattiamoci tutti.
Possiamo essere meglio di così.

Il libro
il libro
S
iate onesti: se il vostro lavoro non esistesse, quanti ne sentirebbero la mancanza? Qual è il contributo significativo che offre al mondo? Nella primavera del 2013, David Graeber ha posto questi semplici interrogativi in un articolo provocatorio pubblicato online, e il successo è stato immediato: milioni di visualizzazioni, traduzioni in quasi venti lingue, condivisioni virali in tutto il mondo, campagne spontanee di guerrilla marketing da parte di attivisti politici. Perché i risultati sono stati sorprendenti: oltre il 40% degli intervistati riteneva di svolgere un lavoro inutile, un lavoro privo di senso, un «bullshit job». A partire da quelle riflessioni e perfezionandole con nuovi dati, ricerche, approfondimenti, Graeber esplora in questo libro una delle più sentite preoccupazioni dell’economia contemporanea, puntando il dito contro una deformazione tipica del capitalismo finanziario che permette a milioni di persone – consulenti per le risorse umane, coordinatori delle comunicazioni, avvocati societari – di svolgere un lavoro inutile senza impedire loro di esserne tragicamente consapevoli. Graeber studia così i meccanismi attraverso i quali questo fenomeno – che il capitalismo efficientista doveva eliminare – si sta diffondendo oltremisura. Analisi spietata e manifesto per un nuovo umanesimo, “Bullshit Jobs” mostra come il lavoro, anziché finalizzato alla produzione, sia diventato fine a sé stesso.
D. Graeber, “Bullshit Jobs”, Garzanti, pag. 400, € 15