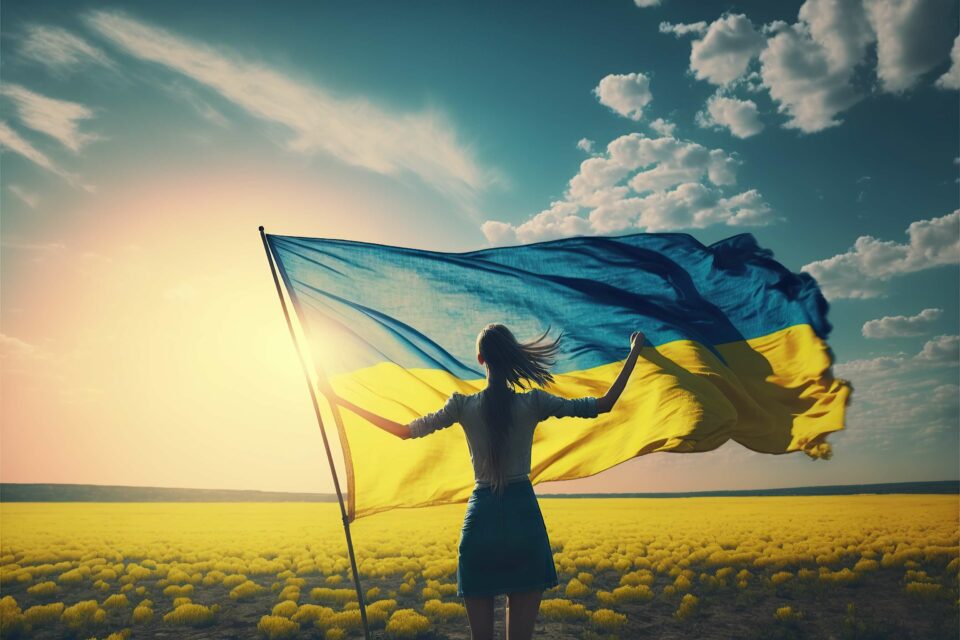
Emma dorme tra le mie braccia: la testolina poggiata al mio petto, l’esile torace che si alza e si abbassa ritmicamente, le manine che stringono il maglione sgualcito. Le lunghe ciglia le sfiorano le gote, una volta rosee e paffute, ora così pallide e sporche di polvere mista a lacrime. Tuttavia, l’espressione del suo dolce, piccolo viso appare ai miei occhi più serena rispetto a poco tempo fa, come se la mia bambina fosse consapevole di aver scampato il pericolo maggiore e di poter ora acquietarsi un poco. Finalmente si sente al sicuro. Finalmente mia figlia è al sicuro. Siamo in Italia. Ci siamo arrivate in aereo ieri sera. Abbiamo lasciato l’Ucraina, la nostra amata terra natia, per metterci in salvo dalla devastazione.
Il mio nome è Yana, ho 32 anni. Abitavo con la mia nuova famiglia, Emma e mio marito Fadey, in un appartamento a Kiev. Eravamo felici: mio marito ed io, entrambi architetti, ci siamo sposati da poco. Abbiamo studiato nella stessa università, architettura per l’appunto, ed è proprio lì che ci siamo conosciuti, quando io frequentavo il secondo anno e Fadey il quarto. Da quel momento il nostro legame ha vacillato più volte, ma non si è mai spezzato, anzi si è corroborato sempre più. Abbiamo condiviso speranze, sogni, timori, ci siamo soccorsi a vicenda nei momenti più difficili. Al mio quarto anno ci siamo fidanzati. Una volta laureato, Fadey non ha faticato a trovare impiego presso uno studio di una certa fama, brillante com’è. Nel frattempo abbiamo fatto progetti per il futuro: sposarci, comprare casa, avere una famiglia. Sognavamo di aprire uno studio tutto nostro, assumere dei dipendenti e costruirci una reputazione. Sogni ambiziosi, certo, ma ci avremmo creduto fino in fondo, come abbiamo sempre fatto, se non fosse successo quel che è successo. Mi sono laureata, ho trovato lavoro, abbiamo comprato una casa confortevole.
C’è stata una pandemia che ci ha costretti a rivedere i nostri piani. Abbiamo aspettato più del previsto prima di aprire un nostro studio, ma il covid ci ha solo rallentati, non ci ha tolto ambizione e determinazione. Nel frattempo abbiamo avuto Emma, che ha portato luce e speranza nuova nelle nostre vite. Stabilizzatasi la situazione, abbiamo finalmente potuto inaugurare la nostra attività. Doveva ancora decollare, ma stavamo lavorando sodo e iniziavamo a raccogliere i primi frutti. Presto i nostri sogni sarebbero diventati pienamente, compiutamente realtà. Ci mancava così poco… Ed è arrivata la guerra. A devastare il nostro Paese e a demolire i nostri sogni. A catapultarci dal nostro quasi raggiunto paradiso all’inferno in terra. A sconvolgere le vite di tutti gli ucraini. A sottrarle, le vite, non solo dei soldati dell’una e dell’altra parte, ma anche di un numero dolorosamente inaccettabile di civili. Gente massacrata dalla violenza assurda e insensata del nemico, case carbonizzate, palazzi sfondati dai missili, intere città rase al suolo.
Era il 24 febbraio del 2022 quando l’esercito russo ha invaso l’Ucraina su più fronti. Il clima era teso da parecchio tempo ormai, ma come prevedere una tale ferocia, una tale implacabilità, una tale disumanità? I miei occhi sono feriti, il cuore spezzato, la mente un turbine convulso di pensieri oscuri e dolorosi. Le mie priorità sono state stravolte. Se prima consistevano nel gestire al meglio lo studio e crescere mia figlia con amore e dedizione, ora la mia unica preoccupazione è salvarla, mia figlia. Anche per Fadey prima di tutto viene il bene mio e di Emma. Lui, però, non è fuggito con noi. Ci ha accompagnate in auto fino al confine con la Polonia. Trenta ore di viaggio, tra le esplosioni e i mezzi militari. Trenta ore di angoscia, con Emma stretta tra le braccia che tremava e piangeva atterrita. Trenta ore di terrore, a chiedersi se uno di quei missili si sarebbe abbattuto sulla nostra auto. Trenta ore che mi sono sembrate settimane, in bilico tra la vita e la morte. Quando siamo arrivati alla frontiera, abbiamo taciuto, tutti e tre, incapaci di parlare. Non c’erano parole che potessero descrivere il nostro stato d’animo. Enorme sollievo, sì, frenato dallo sbigottimento per ciò che i nostri occhi avevano visto e i nostri cuori avevano provato. Sfiniti e sanguinanti, erano i nostri cuori, ma soprattutto schiacciati dalla nube fitta e fosca di depressione che li sovrastava e si faceva più pesante di minuto in minuto.

Come ho detto, Fadey non è rimasto con noi. Non erano questi i suoi piani. Non se la sarebbe mai sentita di abbandonare il suo Paese, dov’è nato e cresciuto, che per lui, e per me, significava passato, presente e futuro, almeno fino a poco tempo fa, in balia del nemico. Non avrebbe mai potuto voltare le spalle e fuggire, assistere dall’esterno alla distruzione della sua patria, della sua casa, senza nemmeno provare a difenderla, derogando questo compito ad altri. Sarebbe stato come arrendersi, darsi per vinto, e questo il mio Fadey non avrebbe mai potuto permetterselo. Ha bisogno di crederci, abbiamo bisogno di crederci, io, lui, tutto il nostro popolo. Così anziché oltrepassare il confine con noi, è tornato indietro, per combattere. Il suo ultimo abbraccio è ancora impresso sulla mia pelle. Mi sono sempre rifugiata tra le sue braccia per alleviare il dolore. Il suo battito lento e cadenzato mi ha sempre fatto dimenticare tutti i miei problemi, donandomi un conforto impareggiabile e facendomi sentire al sicuro. Questa volta, però, non ha funzionato. Il contatto con il suo caldo petto non è riuscito ad alleviare il mio dolore, anzi lo ha acuminato. La consapevolezza che quello poteva essere l’ultimo abbraccio mi ha procurato una fitta lancinante al cuore. È stato duro, sì, e lo è ancora, ma è stato necessario per mettere in salvo la mia piccola. La sua vita vale più di qualsiasi altra cosa, e ora, grazie a Dio, è finalmente salva.
Ora viaggiamo a bordo di un treno che sfreccia in mezzo ai campi coltivati a riso e frumento della Pianura Padana, immersa nella luce morbida del tramonto, verso Milano, dove ci aspetta una famiglia di brave persone, pronta ad accoglierci a braccia aperte nella loro calda casa. I figli della signora Emma, Giacomo e Camilla, non hanno esitato ad offrirmi la loro ospitalità. Già prima che scoppiasse la guerra mi avevano assicurato che, qualora avessi deciso di mettermi al sicuro lasciando l’Ucraina, sarebbero stati felici di accogliermi in casa loro.
Sono nata nel 1990, quattro anni dopo la catastrofica esplosione della centrale nucleare di Chernobyl. Il disastro ha avuto ripercussioni gravi, oltre che sull’economia, su un numero sconcertante di persone, non solo a livello fisico, ma anche mentale. In molti, infatti, hanno perso ogni traccia di speranza nel futuro, il che ha causato un aumento dei comportamenti a rischio: alcolismo, uso di stupefacenti, rapporti non protetti. I miei genitori, purtroppo, sono stati tra le vittime di questo terrificante effetto domino, ed è in questo contesto che mi hanno concepita. Non mi volevano nemmeno, ero frutto di un errore, l’ennesima conseguenza di quella terribile catena di cause ed effetti azionata dalla strage di Chernobyl. Così sono cresciuta in un orfanotrofio, insieme a tanti altri bambini nella mia stessa situazione. Un giorno, avrò avuto sei anni, è stato proposto ad alcuni di noi un cosiddetto soggiorno di risanamento in Italia. Non sapevo esattamente cosa significasse quel parolone così lungo ed estraneo alle mie orecchie di bambina, ma quando mi è stato spiegato a sommi capi che mi si presentava la possibilità di lasciare l’ambiente povero e infelice, oltre che malsano, dove mi trovavo, anche se solo per pochi mesi, non ci ho pensato due volte: avrei colto l’opportunità al volo. Così tutto è stato organizzato tramite associazioni internazionali, e quell’estate sono partita insieme ad altri bambini per l’Italia, un luogo del quale prima di allora non avevamo neanche sentito parlare, e ci pareva così lontano e carico di mistero. Dal canto mio, avevo un sacco di punti interrogativi e di preoccupazioni, ma nel turbine di emozioni che era il mio cuore su tutto prevaleva la speranza e la trepidazione. In Italia fui accolta da una famiglia che abitava in un grazioso paesino sul Lago Maggiore. Fin da subito ho amato quel luogo.
La famiglia che mi ospitava risiedeva in un appartamento di dimensioni modeste ma pulito e luminoso. Fin da subito mi sono sentita accolta e benvoluta, soprattutto grazie alla natura materna e alle costanti attenzioni della signora Emma. Lei e il marito, il signor Giovanni, avevano due figli, Giacomo e Camilla, più o meno della mia stessa età. Si sa come i bambini possano risultare invadenti e offensivi con le loro domande schiette, tuttavia, superata la fase iniziale, abbiamo stretto una meravigliosa amicizia. Ogni estate trascorrevo un paio di mesi insieme a questa imperfetta ma unita famigliola. Di volta in volta il mio vocabolario si ampliava e imparavo a esprimermi sempre meglio in italiano, grazie soprattutto al tempo e allo zelo che dedicavo allo studio di questa lingua durante l’inverno. Passai tanti momenti felici in Italia, instaurai un legame di profondo e sincero affetto reciproco con tutta la famiglia. La signora Emma diventò la mia figura di riferimento, sapevo che mi amava quasi quanto i suoi figli: sono stati lei e il signor Giovanni a pagarmi gli studi universitari, consentendomi di realizzare il futuro che sognavo. Qualche anno fa è venuta a mancare, così ho voluto ricordarla e ringraziarla del suo amore gratuito chiamando mia figlia con il suo nome.
È con immenso calore e sincero trasporto che Giovanni e Camilla mi accolgono, quella notte, nella casa dove trascorrevo le estati da bambina e dove ora abita loro padre. Sono stati tanto in pensiero per me, dicono, e per la mia piccola. Camilla prende tra le braccia Emma, ancora addormentata, stanca com’è, e inizia a cullarla, notando che è bellissima e commuovendosi fino alle lacrime. Giacomo, nel frattempo, mi fa sedere sul divano, mi porta una coperta, da bere e da mangiare. Anche lui è emozionato nel rivedermi sana e salva. È tardi, ma perfino il signor Giovanni è rimasto alzato ad aspettarmi con ansia, ed ora mi sorride con gli occhi lucidi. Camilla mi ha preparato un bagno caldo, un lusso che non mi era concesso da tempo e che mi aiuta ad allentare la tensione in tutti i muscoli del corpo. Quella notte, spossata, riesco ad addormentarmi, e stabilisco un record di quasi due ore ininterrotte di sonno prima di svegliarmi ansimante da un incubo, con le coperte incollate al corpo e la fronte imperlata di sudore. Nelle settimane successive mi tengo il più possibile occupata: mi alzo all’alba, quando tutti dormono ancora, e vado a correre sul lungolago con gli auricolari a tutto volume, per darmi la giusta carica e soprattutto per non pensare, finché non esaurisco il fiato. Tornata a casa, mi inserisco sotto la doccia calda per levarmi di dosso il sudore e cercare di rilassarmi. Il resto della giornata la spendo a occuparmi di Emma e del signor Giovanni, che è anziano, a fare i mestieri, cucinare, sempre con il televisore acceso. In questo modo tengo le mani e la mente occupate: ne ho bisogno, altrimenti credo che impazzirei d’angoscia. La sera, quando ho esaurito le cose da fare e tutti vanno a letto, mi ritrovo per la prima volta in tutta la giornata con la mente libera. Allora inizio a pensare all’Ucraina, alle ultime notizie, che non sono per nulla confortanti, alle atrocità che continuano a venir compiute, alla sofferenza e alla devastazione che dilaga nel mio Paese. Ma i miei pensieri convergono tutti su Fadey, rimasto a combattere una guerra impari, sanguinosa, e che non accenna a cessare. Ogni tanto mi telefona, e quando sento la sua voce dall’altro capo della linea tiro un enorme sospiro di sollievo e al contempo mi si spezza il cuore: mi manca terribilmente, e ho una maledettissima paura di non vederlo mai più che mi attanaglia lo stomaco giorno e notte, senza sosta, senza pietà, da quando l’ho lasciato alla frontiera.
La verità è che mi sento in colpa, mi sento terribilmente in colpa: mentre io sono qui in Italia al sicuro, circondata da persone che mi vogliono bene e si preoccupano per me, Fadey sta combattendo per l’indipendenza del nostro Paese, per difendere gli ideali che condividiamo entrambi, rischiando la vita ogni singolo istante. Sono questi i pensieri che spingono prepotentemente per imporsi nella mia testa. Una mattina, mentre corro, mi devo fermare: sono esausta, le gambe mi tremano, la testa mi gira, i polmoni si riempiono avidamente d’aria, in debito d’ossigeno. Metto gli auricolari nella tasca della felpa grigia oversize che Giacomo mi ha prestato e mi appoggio con le mani sulla ringhiera affacciata sul lago. Il sole sta sorgendo: i primi, flebili raggi si allungano sullo specchio d’acqua perfettamente piatto che riflette un cielo limpido, terso, i cinguettii acuti dei passeri si diffondono nell’aria gelida del mattino. Questo paesaggio non riflette neanche lontanamente il mio stato d’animo: non sopporto più di vivere nell’angoscia e nel senso di colpa, la morsa allo stomaco si è fatta tanto stretta da togliermi il fiato, ogni secondo sono sull’orlo di un attacco di panico. Non posso andare avanti così…
Il piano che sto covando mi si presenta ora come l’unica opzione, l’unica strada percorribile. Amo tanto Emma, e sarebbe difficilissimo separarmi da lei, ma almeno so che è in buone mani, lontana dalla guerra, e che, nella peggiore delle ipotesi, Giacomo e Camilla non la lasceranno mai sola. Mi si spezza il cuore fare una scelta del genere, sapendo come ci si sente ad essere abbandonati dai propri genitori, ma, in fin dei conti, lo faccio anche per lei. Perché l’Ucraina è anche la sua, di casa, e forse un giorno potrà viverci in libertà e in serenità. Inoltre, il mio senso morale non mi lascia altra scelta. Giacomo, Camilla e il signor Giovanni rimarranno senz’altro sconvolti quando parlerò loro di ciò, ma, una volta che li avrò resi partecipi del mio stato d’animo, capiranno: sono persone dotate di un’intelligenza e di una sensibilità non comuni e, soprattutto, conoscono i miei principi e i miei ideali. Come avrete oramai intuito, ciò che voglio è tornare in Ucraina per combattere al fianco del mio popolo, al fianco del mio grande amore, Fadey. So che potrei sbagliarmi, Fadey potrebbe essere già morto, ma nel profondo del cuore so che lo troverò e ci riabbracceremo. E poi combatteremo insieme, facendoci coraggio a vicenda, e quel che accadrà, accadrà. Forse moriremo entrambi, o forse ci salveremo. Non posso saperlo. Tutto quello che so è che non mi tirerò indietro.
Il concorso
Il terzo classificato ex-equo nel corso/concorso “Stories d’Istanti” è stato Mattia Basso, dell’ITT Buonarroti
di Trento, con il racconto “Solidarietà”. “Stories d’Istanti”, iniziativa centrata sulla narrazione e i temi della solidarietà, sviluppatasi nel corso del 2022, e rivolta alle scuole del Trentino, è stata organizzata da Ipsiadelle ACLI del Trentino, in collaborazione con il Forum trentino per la pace e Trentino Mese, con il sostegno della Fondazione Caritro. Il percorso si è sviluppato in una serie di incontri con associazioni di volontariato che operano sul territorio provinciale alternate a lezioni sulla scrittura creativa, letteraria e multimediale, tenute da Marco Pontoni (ideatore), Martina Dei Cas, Pino Loperfido, Lisa Pontoni, Soumaila Diawara. La giuria era composta da: Marco Pontoni, giornalista e scrittore, Massimiliano Pilati presidente del Forum, Pino Loperfido, direttore di TM, Olha Vozna coordinatrice di Ipsia, Lisa Pontoni, comunicatrice multimediale.
